|
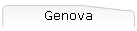



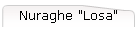
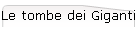
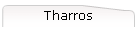

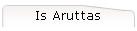
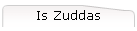

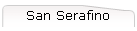
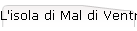
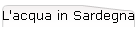
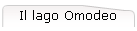
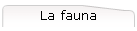
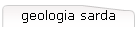

| |
L'origine della cittadina è documentata da un’ epigrafe fenicia del IX sec.
a.C., nulla di certo si conosce dello stanziamento fenicio-punico, che dovrebbe
essere localizzato vicino alla foce del Temo più dell’attuale centro, nell'età
romana sorgeva Bosa Vetus presso l'attuale chiesa di S. Pietro, architettura
romanica (1602), sempre lungo il corso del fiume, ma sempre più a monte rispetto
l'odierna collocazione.
Giovanni Francesco Fara, padre della storia sarda, così scrive nel 1580:
"distrutto il vecchio paese, la nuova Bosa fu ricostruita intorno all'anno 1112
dai Marchesi Malaspina più vicina la mare, sulla riva destra del fiume, ai piedi
di un monte da cui guarda a sud. È cinta di mura, difesa sulla cima della stessa
montagna dalla fortezza di Serravalle, con torri e una doppia cerchia di mura,
in cui vi sono due porte, una che da l'ingresso in città, l'altra nell'agro ad
oriente"; si riferiva soprattutto al celebre Castello Malaspina, che si erige in
posizione strategica sulla sommità del colle Serravalle; attorno al colle si
sviluppò il centro medievale, oggi centro storico assai suggestivo; l'edilizia,
difatti, si è venuta accomodando nella singolare conformazione del colle di
Serravalle, sul quale la città si è dovuta addossare per cercare la protezione
del castello: il centro tordo medioevale di Sa Costa, conserva oggi varie
stratificazioni edilizie, i viottoli seguono le curve del colle, scalinate
interrompono follemente il percorso orizzontale e lungo le stradine acciottolate
che tagliano il colle, collegate tra loro da scalinate in trachite, sorgono le
povere abitazioni. Il quartiere, in grave degrado, è attualmente quasi spopolato
nella parte più alta, verso il castello, dato che è in corso un intervento di
recupero; ovviamente anche nella pavimentazione del centro storico non poteva
mancare il basalto.
Il castello è quindi il monumento più importante della città, anzi è il fulcro
di essa, e nel corso della storia è stato modificato innumerevoli volte a
piacimento del signore di turno, ma l'intervento più consistente è quello
relativo alla costruzione della torre maestra che sembrerebbe un saggio che
prepara la costruzione della Torri di S. Pancrazio e dell'Elefante nel castello
di Cagliari, opera dell'architetto Giovanni Capula, datata ai primi del 1300.
Dentro le mura della fortezza, poco più indietro del bastioneterrapienato,
guarda il mare l'antica cappella feudale. Dedicata fin dal suo sorgere a S.
Giovanni Battista, successivamente prende il titolo di S. Andrea Apostolo.
L'origine è da riferirsi al XIV secolo, periodo in cui fu ampliata e realizzata
la cappella palatina a una navata; recentemente, durante lavori di
ristrutturazione, sono stati ritrovati nella pareti una serie di affreschi
databili alla metà del XIV secolo e all'ambito della pittura italo - meridionale
di cultura franco - sveva. Assai suggestiva la festa della Madonna di Regnos
Altos che si celebra ogni anno nella seconda settimana di settembre e che
coinvolge tutto il centro storico.
Durante i secoli di dominio della Corona di Spagna, Bosa divenne una delle sette
Città Regie della Sardegna e sotto i Savoia vi fu un effettivo rilancio delle
sue attività produttive, che toccheranno il loro apice nel 700 e nel 800. Nella
prima metà dell’Ottocento la città si dà un volto dignitoso con un’edilizia di
gusto anche nelle espressioni più modeste. L’incremento demografico è debole,
pur se in questo secolo si realizzano trasformazioni urbanistiche significative.
Insieme all’acquedotto, infatti, viene realizzata la rete fognante; intorno al
1870 viene costruito un nuovo porto, costituito in pratica da una scogliera che
univa l’isola Rossa alla sponda sinistra del Temo. La popolazione conosce
un’evoluzione molto modesta anche nel corso del Novecento ed è proprio grazie a
questa sua scarsa vitalità che Bosa ha potuto mantenere una fisionomia storica e
d’ambiente del tutto sconosciuto in altre città dell’isola.
Altra tipicità di Bosa sono le concerie, dichiarate monumento nazionale nel
1989. Si trovano sulla sponda sinistra del fiume nel quartiere artigianale di
Sas Conzas: grandi fabbricati che si affacciano sul
Temo, destinati dal '700 alla
concia delle pelli, vero e proprio relitto di archeologia industriale. Si tratta
di una schiera di edifici a due piani con tetto a doppio spiovente e grandi
finestre, costruite nella prima metà dell’Ottocento lontano dal centro abitato
per via dei cattivi odori prodotti durante le prime fasi di lavorazione, ma
abbastanza vicino al fiume per l’approvvigionamento idrico.
La tradizione conciaria a Bosa risalirebbe almeno ai tempi dei Romani, se non
addirittura più antica, e sarebbe perdurata fino alla metà del Novecento quando
l’ultima conceria chiuse definitivamente i battenti. Oggi, alcuni edifici sono
riutilizzati, non di certo come abitazioni, ma per mostre o simili, altri invece
sono lasciati al degrado.
|
|

|
|
le concerie di Bosa che si affacciano sul Temo
|
|

|
|
Il fiume Temo che attraversa la città di Bosa
|
|
|
|
