 |
Arthur
Schopenhauer nasce a Danzica il 22 febbraio 1788, da un ricco
commerciante e da una scrittrice di romanzi. Alla morte del padre,
nel 1805, gli succede per breve tempo nell'attività commerciale, ma
poi decide di dedicarsi agli studi di molteplici discipline
(medicina, scienze naturali, letteratura, storia e filosofia).
Infine si laurea in filosofia, all'Università di Jena, con la tesi
"Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente"
(1813). Nel dicembre del 1818 pubblica "Il mondo come volontà e
rappresentazione", la sua opera più conosciuta. Muore a Francoforte
sul Meno il 21 settembre 1861. |
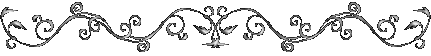
Con il termine pessimismo è definita ogni dottrina filosofica basata sulla teoria della
costante prevalenza del male sul bene. Anche per Schopenhauer si può parlare
di pessimismo, in quanto il filosofo sostiene che la vita non è altro che
dolore, lotta ed incertezza. Egli afferma che l’essere è la manifestazione
di una volontà infinita, cioè un impulso irresistibile che ci spinge ad
esistere e ad agire, che lui chiama Volontà di vivere. Volere significa
desiderare e desiderare significa trovarsi in uno stato di tensione per la
mancanza di qualcosa che non si ha. Il desiderio è quindi assenza, vuoto,
indigenza: ossia dolore. E poiché l’uomo è destinato a soffrire
maggiormente, rispetto a tutti gli altri enti, per l’insoddisfazione del
desiderio e le offese dei mali, risulta il più bisognoso e mancante degli
esseri, condannato a non trovare mai un appagamento definitivo. Anzi, la
stessa soddisfazione finale è solo apparente: un desiderio appagato ne crea
un altro. La gioia è quindi una cessazione del dolore, mentre non si
può dire che quest'ultimo sia la fine di un piacere. L’individuo può
sperimentare una catena di affanni, senza che questi siano preceduti da
altrettanti piaceri, mentre ogni appagamento nasce dalla cessazione di una
preesistente tensione fisica e psichica. Il piacere riesce a vincere il
dolore solo a patto di annullare se stesso, non appena viene meno lo stato
di tensione cessa anche il godimento (esempio di “felicità negativa”).
Accanto al dolore e al piacere, come terza situazione di base c’è la noia,
la quale subentra quando vengono meno le preoccupazioni e il desiderio. “La
vita è come un pendolo che oscilla incessantemente fra dolore e noia,
passando per l’intervallo fugace del piacere”. La Volontà di vivere si
manifesta in tutte le cose, perciò il dolore non riguarda solo l’uomo, ma
ogni creatura (sofferenza universale). Quindi il male si trova nel Principio
stesso da cui dipende il mondo (pessimismo cosmico). L’individuo
appare come uno strumento per la specie, fuori della quale egli non ha
valore. Di conseguenza, l’unico fine della Natura sembra esser quello di
perpetuare la vita, e con la vita, il dolore. Il fatto che alla Natura
interessi solo la sopravvivenza della specie trova una sua manifestazione
nell’amore, uno dei più forti stimoli dell’esistenza. Il fine dell’amore, o
lo scopo per cui esso è voluto dalla Natura, è solo la perpetuazione della
specie. Quindi l’uomo è lo zimbello della Volontà di vivere proprio là dove
crede di realizzare maggiormente il proprio godimento e la propria
personalità. Per questo l’amore procreativo viene inconsapevolmente
avvertito come “peccato”. Esso commette il maggiore dei delitti: la
perpetuazione di altre creature destinate a soffrire. L’unico amore di cui
si può tessere l’elogio è quello disinteressato, la pietà.
Schopenhauer, facendo proprie alcune sentenze pessimistiche a lui precedenti
(saggi d’Oriente, Platone, tradizione biblico-cristiana), afferma che
l’esistenza, in virtù del dolore che la costituisce, si comincia poco per
volta a non volerla. Allo stesso tempo però rifiuta e condanna il
suicidio: primo poiché
esso è un atto di forte affermazione della
Volontà; secondo, perché sopprime solo una manifestazione di quest’ultima,
non essa stessa, che rinasce in mille altri enti. Di conseguenza la vera
risposta al dolore del mondo sta nella liberazione dalla
Volontà di vivere,
che avviene attraverso tre stadi: arte, morale e ascesi. L’arte è la
conoscenza libera e disinteressata, che si rivolge alle idee; in essa una
forma particolare d’amore o di guerra diventa l’Amore e la Guerra, cioè
l’essenza immutabile di questi fenomeni. Chi contempla le idee dunque, è il
puro soggetto del conoscere, non più l’individuo naturale; quindi essa
sottrae l’uomo dalla catena infinita dei bisogni e dei desideri quotidiani,
con un appagamento immobile e compiuto. Per questa ragione si rivela
catartica per essenza, siccome l’uomo, grazie ad essa, più che vivere
contempla la vita, elevandosi sopra la Volontà, il dolore e il tempo. Ma
poiché la funzione liberatrice dell’arte è pur sempre temporanea e parziale,
si rivela essere solo un conforto alla vita stessa. L’etica invece,
implicando un impegno nel mondo a favore del prossimo, è un tentativo di
superare l’egoismo e di vincere quella lotta incessante degli individui tra
loro, che rappresenta una delle maggiori fonti di dolore. Essa non sgorga da
un imperativo categorico dettato dalla ragione, ma da un sentimento di pietà
e da un’esperienza vissuta, attraverso cui avvertiamo come nostre le
sofferenze degli altri. Tramite la pietà sperimentiamo quell’unità
metafisica di tutti gli esseri, che la filosofia teorizza e i testi delle
Upanishad (parte conclusiva dei Veda, cioè i libri trasmessi oralmente dai
Poeti-Profeti dell’antica India ai loro discepoli), esprimono con la formula
Tat Twan Asi (“questo vivente sei tu”). Il tormentatore e il
tormentato quindi, distinti fenomenicamente, sono, noumenicamente, una
stessa realtà. La morale si concretizza in due virtù cardinali: la giustizia e la
carità (o àgape). La prima ha un carattere
negativo, poiché consiste nel non fare il male e nell’essere disposti a
riconoscere agli altri ciò che siamo pronti a riconoscere a noi stessi. La
seconda s’identifica invece con la volontà positiva e attiva di far del bene
al prossimo. L’etica rimane però sempre all’interno della vita e presuppone
un attaccamento ad essa. Schopenhauer invece, si propone il traguardo di una
liberazione totale dall’egoismo, dall’ingiustizia e dalla Volontà di vivere
tramite l’ascesi. Essa nasce dall’orrore dell’uomo per un mondo di
dolore ed è l’esperienza per la quale l’individuo si propone di estirpare il
proprio desiderio di esistere, attraverso la castità, il digiuno, l’umiltà,
la povertà e il sacrificio. Se tale Volontà fosse vinta totalmente in un
solo individuo, essa perirebbe del tutto, poiché è unica e indivisibile.
|