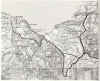Cenni storici
| Le prime
notizie riguardo l'impaludamento della valle dell'Ospo risalgono
all'anno 1000; questo avvenimento rese infatti la foce del corso
d'acqua un terreno adatto alla costruzione di peschiere e saline, a
quei tempi due importanti settori dell'economia delle cittÓ
costiere.
Il potenziamento delle saline fu probabilmente dovuto ai monaci dell'ordine dei Templari, i quali si insediarono in questa zona nel Medioevo per dare assistenza ai pellegrini slavi e tedeschi diretti in Terra Santa o nei santuari italiani. L'attuale Rio Ospo si chiamava "fiume di San Clemente", ed i viandanti erano accolti nella "domus Sancti Clementis" che sorgeva nell'omonima valle.
L'attivitÓ delle saline dur˛ fino al 1827, anno in cui un decreto governativo austriaco ne ordin˛ l'abbandono. La Valle delle Noghere fu allora occupata da paludi e canneti e questo naturale processo di interramento fu accelerato in seguito ad attivitÓ antropiche che interessarono la sua zona.
|
Tra il 1953 e il 1959 la valle pass˛ sotto l'amministrazione dell'EZIT che vi oper˛, tramite lavori di bonifica, di arginamento, di copertura e rettifica del corso dei torrenti, notevoli trasformazioni morfologiche. Nel 1968 alla zona industriale fu annessa un'area di Rabuiese occupata dalla Fornaci Valdadige, una fabbrica di laterizi che sfruttava una cava d'argilla situata lungo la sponda sinistra del Rio Ospo.
Lo stabilimento delle Fornaci Valdadige in una foto degli anni '60 Quest'industria cess˛ la produzione nel dicembre del 1973 e fu completamente sgomberata nel 1974. Da allora negli scavi abbandonati si formarono circa una quindicina di "laghetti"; alcuni di essi furono interrati per la costruzione delle nuove fabbriche, altri furono utilizzati come discariche, i rimanenti sono attualmente sotto tutela per il loro notevole interesse naturalistico. Alcuni "laghetti" sono stati inseriti da Silvio ed Elio Polli nel catasto degli stagni della Provincia di Trieste assegnando loro i numeri dal 53 al 60. Questi rilievi sono stati fatti nel 1981 e nel 1983 e da allora l'area in questione ha subito ulteriori modifiche. |