 |
Nicolò Ugo Foscolo
nacque nel 1778 nell'isola greca di Zante, alla morte del padre si
trasferì a Venezia con la madre. Egli fu molto attivo politicamente
tanto che nel 1798 si arruolò nell'esercito di Napoleone. Ma quando,
con il trattato di Campoformio, Venezia venne ceduta all'Austria
Foscolo si allontanò dalla città e visse un periodo a Firenze e a Milano.
Dopo la sconfitta e l'abdicazione di Napoleone decise di andare in
esilio prima in Svizzera e poi a Londra dove morì nel 1827, stanco,
ammalato e povero. Ora le sue ceneri sono nella chiesa di Santa
Croce a Firenze, che egli aveva cantato nei Sepolcri. |
|
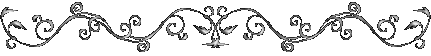
Il periodo in cui visse Foscolo è caratterizzato da cambiamenti dal punto di
vista letterario e culturale. In Europa, soprattutto in Inghilterra e in
Germania, si era già sviluppata la corrente del romanticismo, mentre in
Italia questo pensiero trovò una certa difficoltà ad espandersi poiché era
ancora molto diffusa la corrente neoclassica. Per questo motivo Foscolo può
essere definito come un neoclassico-romantico perché nella sua opera sono
evidenti temi appartenenti a entrambe le correnti. Il concetto della morte
che traspare dalle sue opere è tipico del romanticismo. Il neoclassico aveva
portato a una riscoperta del mondo antico, a seguito di questi avvenimenti i
letterati e i poeti sono portati a riflettere sulla caducità delle cose e
sul passare del tempo. Essi si interrogano e meditano sul senso della vita e
sulla morte. Con il romanticismo comincia quindi ad avere importanza l'io
dell'individuo che vede la realtà a modo suo e ed esprime le proprie
sensazioni. La morte e il suo rapporto con la vita sono dei temi centrali
della corrente del romanticismo.
Secondo Foscolo la morte è la
liberazione da tutti i mali; nel suo pensiero
è assente la dimensione trascendente, non vi è, infatti, alcuna consolazione
religiosa o speranza nell'al di là. La concezione della morte di Foscolo
traspare dal romanzo epistolare "Ultime lettere di Jacopo Ortis", storia di
un giovane patriota che dopo aver visto svanire tutti i propri sogni, spinto
dalla disperazione amorosa e politica si suicida. Il protagonista rispecchia
l'autore, entrambi sono stati vittime della delusione politica e amorosa.
"Veggo la meta: ho già tutto fermo da gran tempo nel cuore- il modo, il
luogo- né il giorno è lontano.
Cos'è la vita per me? Il tempo mi divorò i momenti felici: io non la conosco
se non nel sentimento del dolore: ed or anche l'illusione mi abbandona-
medito sul passato; m'affiso sui dì che verranno; e non veggo che nulla.
Questi anni che appena giungono a segnare la mia giovinezza, come passarono
lenti tra i timori, le speranze, i desiderj, gl'inganni, la noja! e s'io
cerco la eredità che mi hanno lasciato, non mi trovo che la rimembranza di
pochi piaceri che non sono più, e un mare di sciagure che atterreno il mio
coraggio, perché me ne fanno paventar di peggiori. Che se nella vita è il
dolore, in che più sperare? Nel nulla; o in un'altra vita diversa sempre da
questa.---
Ho dunque deliberato non odio disperatamente me stesso; non odio i viventi.
Cerco da molto tempo la pace e la ragione mi addita sempre la tomba. Quante
volte sommerso nella meditazione delle mie sventure io cominciava a
disperare di me! L'idea della morte dileguava la mia tristezza, ed io
sorrideva per la speranza di non vivere più- Sono tranquillo, tranquillo
imperturbabilmente. Le illusioni sono svanite; i desiderj son morti: le
speranze e i timori mi hanno lasciato libero l'intelletto. Non più mille
fantasmi ora giocondi ora tristi confondono e traviano la mia immaginazione:
non più vani argomenti adulano la mia ragione; tutto è calma- Pentimenti sul
passato, noja del presente, e timor del futuro; ecco la vita. La sola morte
a cui è commesso il sacro cangiamento delle cose, promette pace".
[frammento lettera da Rimino 5 marzo]
Nelle lettere finali c'è un climax ascendente che porta l'Ortis a una
crescente disperazione fino a giungere al suicidio.
La situazione politica sembra che ormai non può avere alcun risvolto
positivo, Teresa, la donna che ama e per cui continua a vivere, si è appena
sposata con Odoardo, suo rivale, lui dice che non vuole amare la moglie di
Odoardo. Non sembra esserci altra via di fuga che la morte.
Le parole-chiave del suo universo esistenziale "timori", "speranze", "desiderj",
"inganni", "noia" e soprattutto "rimembranza" e "illusione", sono tutte
sovrastate dall'idea della morte.
La morte per Jacopo Ortis è un qualcosa di ben atteso, egli non la teme ma
la aspetta con ansia, aspetta il momento in cui potrà lasciare questa vita
piena di sofferenze e di dolori.
Con il carme "I Sepolcri" la visione della morte cambia, vi è una speranza
di vita dopo la morte, non in una dimensione trascendente ma nel ricordo e
nel pianto delle persone care.
Il carme fu scritto in occasione dell'editto di Saint-Cloud, emanato da
Napoleone in Francia nel 1904 ed esteso in Italia nel 1906, quando Foscolo
aveva già ultimato la stesura della sua opera, ciò significa che l'autore
temeva che tale editto venisse promulgato anche in Italia. Tale editto
imponeva di seppellire i morti in cimiteri extraurbani (per motivi igienici)
e in fosse comuni e anonime (per rispetto del principio dell'egualitarismo). Esso
in realtà riprendeva una disposizione del governo austriaco che, a causa
dell'opposizione popolare, aveva avuto breve durata, ma era riuscito a
valere sulla sepoltura di Parini, morto nel 1799 e sepolto in una fossa
comune.
Il carme è dedicato a Ippolito Pindemonte che aveva anche lui iniziato la
stesura di un poemetto in 4 libri intitolato "I Cimiteri" che aveva
interrotto non appena aveva saputo che anche Foscolo stava lavorando sullo
stesso argomento.
Secondo Foscolo i sepolcri, inutili ai morti, sono utili ai vivi. Non vi è
alcuna vita dopo la morte me il defunto può continuare a vivere nel ricordo
delle persone care. Solo per chi lascia eredità d'affetti ha una qualche
speranza di continuare a vivere. Per fare ciò è fondamentale che i corpi
degli esuli possano ritornare in patria e che la lapide conservi i nomi dei
morti. Perciò è disumana la legge che impedisce il culto dei morti e che
permette che il corpo di un uomo onorato come Parini possa giacere accanto a
quello di un infame [vv.1-90].
Eppure il culto dei morti è stata una delle prime istituzioni che si sono
dati gli uomini quando hanno cominciato a vivere in comunità e hanno
instaurato delle leggi. Non sempre i sepolcri sono stati motivo di terrore
come nelle abitudini dei cristiani moderni che seppelliscono i cadaveri tra
le mura delle città e delle chiese, anzi i cimiteri delle civiltà pagane
(Greci e Romani), e quelli inglesi, sono situati in giardini, sotto l'ombra
degli alberi, ornati di fontane e di fiori; luoghi accoglienti dove è
piacevole il dialogo con il defunto [vv.91-150].
Le tombe degli uomini illustri ispirano i vivi a compiere grandi imprese,
come quelle della chiesa di Santa Croce che aveva ispirato e confortato
Alfieri, e quelle dei Martiri di Maratona che erano state costruite per
ricordare la virtù degli eroi greci [vv.151-212].
Anche le tombe vengono
consumate dal tempo, così aspetta al poeta il compito di eternizzare le
gesta degli eroi. Omero è il Poeta in quanto è riuscito a far continuare a
vivere per millenni le gesta degli eroi greci e troiani, grazie a lui Ettore
non viene ricordato come eroe sconfitto ma come eroe che ha combattuto ed è
morto per salvare la patria [vv.213-295].
CRITICA
La prima recensione al carme è comparsa nel 1807, l'anno della sua
pubblicazione, sul "Giornale Italiano" opere dell'abate francese Amato
Guillon.
"Sembraci che sia questo un fine ben brusco in un'opera di sentimento. Si
direbbe che un simil soggetto avesse troppo stancato la lira del poeta, per
poter avanzare di più. L'andamento del suo poema era già diventato penoso
quando la sensibilità non animava più la sua musa; ed essa aveva già cessato
di spargere la sua bellezza nei di lui versi, allorché egli dai sepolcri
presenti si era trasportato a quelli dei tempi eroici della Grecia. Questa
transizione l'ha condotto a dei dettagli d'erudizione; ora l'erudizione
inaridisce il sentimento: e quindi ne viene che questa seconda parte della
sua elegia, che ha una certa disparità colla prima, interessa molto meno la
nostra anima, e conviene molto meno a quella dolce voluttà che essa trova ad
intenerirsi sulle ceneri dei nostri simili".
Amato Guillon sostiene che i Sepolcri siano un'opera di sentimento, e che il
sentimento viene rovinato dai dettagli di erudizione alla fine. La seconda
parte, quando Foscolo passa dai sepolcri attuali a quelli dei greci, è
secondo il Guillon, peggiore della prima poiché non riesce a interessare il
lettore, inoltre essa è completamente diversa dalla prima.
Questa critica fece infuriare subito Foscolo che rispose al prete con una
lunga "Lettera a Monsieur Guillon su la sua incopetenza a giudicare i poeti
italiani". Foscolo dice che le osservazioni coprono di ridicolo il prete, e
che il suo poema non è elegiaco ma lirico. Riguardo alla critica della
seconda parte dei "Sepolcri" Foscolo scrive:
"Recito intero quest'ultimo squarcio dannato da lei come "arido di
sentimento", perché a me anzi pare, non "che il soggetto abbia stancato la
lira" del poeta, ma che egli abbia fin da principio temperate le forze per
valersene pienamente in questo luogo. Per per-suaderci delle sue sentenze su
la santità e la gloria dei sepolcri, egli ci presenta un monumento che
superò le ingiurie di tanti secoli. Le Troiane che pregano scapigliate sul
mausoleo de' primi prìncipi d'Ilo, onde allontanare dalla lor patria e da'
loro congiunti le imminenti calamità - la vergine Cassandra che guida i
nipoti giova-netti a piangere su le ceneri de' loro antenati - che li
consola dell'esilio e della povertà decretata dai fati, profetando che la
gloria dei Dardanidi risplenderà sempre in quelle tombe - la preghiera alle
palme e a' cipressi piantati su quel sepolcro dalle nuore di Priamo, e
cresciuti per le lacrime di tante vedove - la benedizione a chi non
troncherà quelle piante sotto l'ombra delle quali Omero, cieco e mendìco,
andrà un giorno vagando per penetrar negli avelli ed interrogare gli spettri
de' re troiani su la caduta d'Ilo onde celebrar le vittorie de' suoi
concittadini - gli spettri che con pietoso furore si dolgono che la lor
patria sia due volte risorta dalle prime rovine per far più splendida la
vendetta de' Greci, e la gloria della schiatta di Peleo alla quale era
riservato l'ultimo eccidio di Troia - Omero che, mentre tramanda i fasti de'
vincitori, placa pietosamente col suo canto anche l'ombre infelici de' vinti
- tanti personaggi, tante passioni, tanti atteggiamenti, e tutti raccolti
intorno a un solo sepolcro, sembrano a lei senz'anima e senza invenzione? E
la fine, la fine sopra tutto, sente di languore? Questo squarcio è un
vaticinio di una principessa di sangue troiano, sorella d'Ettore, e
sciagurata per le sventure che prevedeva. Non può dissimulare la gloria de'
distruttori della sua famiglia, ma ella cerca alcuna consolazione
vaticinando per l'infelice valore d'Ettore una gloria più modesta e più
santa; non d'un principe conquistatore, ma d'un guerriero caduto difendendo
la patria. Nelle ultime parole di Cassandra: "e finché il sole risplenderà
sulle sciagure umane", l'autore s'è studiato di ricorre tutti i sentimenti
di una vergine profetessa, che si rassegna alla fatale e inevitabile
infelicità de' mortali, che la compiange negli altri perché sente tutto il
dolore della sua propria, e che, prevedendola perpetua su la terra, la
assegna per termine alla fama del più nobile e del men fortunato di tutti
gli eroi. Ove l'autore avesse mirato al "patetico", avrebbe amplificati
questi effetti; mirava invece al "sublime", e li ha concentrati".
Il Foscolo così concludeva la risposta: "Ma così va il mondo, Monsieur
Guillon! la colpa è d'altri, pur troppo, e noi n'abbiam l'onta e la pena:
ella parlando di ciò che non intende; io rispondendo a chi non può
intendermi".
Foscolo con questa risposta vuole far capire che il carme non è
sentimentale, ricorda soltanto le virtù degli eroi che hanno combattuto per
la loro patria, seppur sono stati sconfitti, il loro ricordo vivrà
nell'eternità, se Foscolo avesse voluto rendere la lirica sentimentale
avrebbe ampliato questi effetti, invece li ha solo concentrati.
Foscolo poi in una lettera del 6 maggio 1808, rispondeva a qualcuno che
aveva criticato il tono troppo aspro della risposta, così scriveva:
"Quello che fu scritto da me non mi fu dettato, credetelo, dall'albagìa di
Autore, ma dal sentimento del nome Italiano. Il Guillon, prete - non - prete
francese, compilatore della parte letteraria del Giornale Italiano, mordeva
spietatamente tutti gli italiani, e s'avventava a occhi ciechi. E' viltà
calare la spada su que' cani, ma è pazienza fratesca il lasciarli abbaiare;
quel mio libricciuolo fe' uscire donne, ragazzi e chierici dalle case, da'
collegi e da' seminari, e lo cacciarono a sassate; da quel giorno in poi
lascia in pace gli autori italiani morti e vivi".
Diversi furono i giudizi di De Sanctis e Carducci, i maggiori critici
letterari dell'Ottocento, espressero giudizi esaltanti. De Sanctis affermò
che: "...questo carme è la prima voce lirica della nuova letteratura,
l'affermazione della coscienza rifatta, dell'uomo nuovo... Il carme è una
storia dell'umanità da un punto di vista nuovo, una storia de' vivi
costruita da' morti. Senti una ispirazione vichiana in questo mondo, che
dagli oscuri formidabili inizi naturali e ferini la religione de' sepolcri
alza a stato umano e civile, educatrice di Grecia e d'Italia; il doppio
mondo caro al Foscolo, che unisce in una sola contemplazione Ilio e Santa
Croce"; De Sanctis non esalta in egual modo il romanzo "Ultime lettere di
Jacopo Ortis" e lo riduce a una ibrida "poesia in prosa", fallimento sia in
poesia che come romanzo. Carducci: "[I Sepolcri sono] la sola poesia lirica
nel significato pindarico che abbia l'Italia".
Dei critici a noi più vicini citiamo solo alcuni giudizi che ci sembrano
più interessanti.
Momigliano:
"I Sepolcri sono la prima data della nostra letteratura patriottica di fondo
storico, sono il ritratto ideale del Foscolo, sono - sopra tutto - la
consacrazione poetica d'una nobile e triste religione della civiltà e della
vita;...sono una breve e immensa sinfonia della vita e della morte";
Citanna:
"La religione dei Sepolcri... era in fondo la religione della poesia,
l'esaltazione della sua stessa opera ideale di poeta";
Ramat:
"I Sepolcri sono la divina Commedia del Romanticismo, perché vi si canta il
dramma dell'anima che dall'inferno del materialismo meccanicistico,
attraverso il purgatorio della nobile illusione, giunge al paradiso della
certezza storica; certezza che lo spirito vince la materia, la vita trionfa
della morte, anzi la morte si trasfigura in vita".
Nel dopoguerra la figura di Foscolo risulta più difficile da avvicinare
anche per la complessità del suo linguaggio poetico.
|
